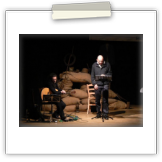Giovanni Pacher - Gruppo Alpini Roncegno
Menu principale:
Giovanni Pacher
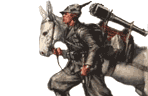


GIOVANNI PACHER
"GIOCANDO A CARTE CON LA MORTE"
di Marika Caumo
 Sul fronte greco albanese prima, francese poi. Prigioniero dei tedeschi, la fuga e la cattura dei partigiani francesi. Quindi la liberazione americana. In mezzo la fame, il freddo, le bombe, la paura di morire. Già perché l'alpino Giovanni Pacher la morte se l'è trovata di fronte più volte tra l’ottobre 1940 e il settembre 1945.
Sul fronte greco albanese prima, francese poi. Prigioniero dei tedeschi, la fuga e la cattura dei partigiani francesi. Quindi la liberazione americana. In mezzo la fame, il freddo, le bombe, la paura di morire. Già perché l'alpino Giovanni Pacher la morte se l'è trovata di fronte più volte tra l’ottobre 1940 e il settembre 1945.
Nato a Roncegno il 3 luglio 1920 da Luigi e Erminia (Nana) Michelon, Giovanni in paese è ricordato soprattutto per il negozio di frutta e verdura di famiglia, che chiuse nel 1991, dopo 70 anni di attività. Nel 1956 approdò in Comune e ci rimase oltre 10 anni, prima come assessore e poi, nel 1960, come vicesindaco. Giovanni è scomparso il 27 settembre 2011, appena un mese dopo Luigi Baldessari.
La "sua" guerra è stata raccolta e resa pubblica dal giornalista Davide Modena, che dopo un approfondimento dal titolo "In guerra per 2.400 lire" apparso su Roncegno Notizie del marzo 2007 (una sorta di diario da cui sono estratti i dialoghi riportati sotto), decise che quella storia meritava maggiore spazio. Nasce così il suo primo libro, "Bestia e Sapone. La guerra dell'Alpino Giovanni Pacher", presentato a Roncegno il 14 dicembre 2008
La cartolina arrivò nel marzo 1940: fu assegnato alla 74ª Compagnia, XI Reggimento Alpini, V Divisione, la “Pusteria”. Il 10 giugno l’Italia entrò in guerra e Pacher passò nel Battaglione Bolzano. Nell’ottobre partì per il fronte greco-albanese sulla nave Garibaldi.
Dicembre 1940. «Ci trovavamo sulla cima di una montagna. I greci stavano salendo. Il sergente maggiore era Bernardi da Novaledo che comandava la squadra dei mitraglieri. Mi disse: “Piazza la mitraglia sul nèto”, cioè in campo aperto. Gli risposi: “La mettiamo dietro a un crozo”. “No – disse - che da qui li vediamo meglio”. “Faccio come dici - replicai - ma io qui non ci sto”. Al mio posto mise un commilitone. Riuscì a tirare una sola raffica prima di venire centrato a morte da un colpo di mortaio.
Il sergente Bernardi venne ferito. Me lo caricai sulle spalle. A metà avvallamento mi scivolò a terra. Morto. Ero stato ferito ad un piede. Dopo due ore non riuscivo più a camminare. Mi trovavo allo scoperto. Non potevo alzarmi in piedi perché mi avrebbero ucciso. Dopo 2-3 ore cominciavo ad avvertire un forte dolore alla schiena. Sapevo che era un sintomo di assideramento. Vidi un’ombra passare. Mi sembrava dei nostri. L’avevo riconosciuto, era di Asiago. Mi prese per la giacca e mi trascinò per oltre un’ora su quel pianoro. Fino a che arrivammo in una boscaglia. Allora mi caricò sulla schiena e mi portò al punto di pronto soccorso. Arrivammo verso mezzanotte. ... La mattina dopo arrivò il medico. Non riuscì a togliermi la scarpa, dovette tagliarla. La ferita avrebbe avuto bisogno di punti di sutura, di essere disinfettata. Ci vollero quattro giorni prima di trovare un ospedale. Arrivammo a Tepeleni (Albania), ma ci dissero che non c’era posto. Quindi a Valona. Per ospedale trovammo stalle di cavalli e mucchi di paglia. Con pidocchi a non finire. Aspettammo altri due giorni prima che ci visitasse un medico. Ormai i piedi non li sentivo più. “Ti manderemo in Italia, ti medicheremo sulla nave”, mi dissero. La nave arrivò. Ci misero una settimana a caricarla. Portava 1.200 persone. Quando mi visitarono i piedi erano pieni di macchie nere. Cominciarono a tagliare con il bisturi ma non sentivo nulla. ... Da Valona partimmo alla volta di Taranto, sulla nave ospedaliera “Gradisca”. Fu il suo ultimo viaggio, poi venne affondata. Arrivammo a Taranto di sera. Ci accolse un bombardamento americano. Risalimmo l’Italia fermandoci in ogni città per chiedere ospitalità negli ospedali. Fui scaricato in quello militare di Piacenza. La camera d’ospedale era umida, le suore di pessimo umore. Non riuscivo a tenere in mano la gamella, la rovesciai. Mi fecero stare due giorni a digiuno».
Quindi sei mesi di convalescenza a casa e il richiamo ai servizi sedentari. Nell’estate del 1942 la partenza per la Francia come truppe di occupazione, aggregato al Battaglione Trento.
8 settembre 1943. «Giorno dell’armistizio. Lasciata Digne Les Bains (Alta Provenza), ci trovavamo a Grenoble quando fummo catturati dai tedeschi. Della richiesta di armistizio fummo informati solo a sera. Avevamo combattuto tutta la notte. Al mattino, verso le 9, i nostri superiori ci ordinarono di deporre le armi. I tedeschi ci misero dinanzi a tre possibili scelte: “Chi vuol essere fatto prigioniero – dissero – si sposti a sinistra. Chi vuol passare a combattere con noi a destra. I lavoratori rimangano al centro”.Confabulammo un attimo tra noi trentini, alla fine scegliemmo di rimanere fermi: lavoratori. Dopo 10 minuti arrivarono una cinquantina di camion. Caricarono tutti i prigionieri; poi i combattenti. Rimanemmo solo noi lavoratori. Per 20 giorni rimanemmo lì fermi, senza ricevere nulla da mangiare né da bere. ... Ma insistevano perché ci armassimo. Noi non volevamo saperne. Così, una mattina, in stazione trovammo i vagoni-bestiame. Lì iniziò la nostra prigionia».
Li portarono a Romilly sur Seine dove furono impiegati ai lavori forzati per rimettere in sesto l’aeroporto, o a scavare trincee lungo le strade.
Aprile 1944. «Ci portarono a Pointe sur Mer. Eravamo li quando ci fu lo sbarco in Normandia, il 6 giugno 1944. Quella mattina i tedeschi ci portarono subito via. Marciammo all’indietro, verso Parigi, passando da Evreux. Ci trovavamo su una collina sopra la città, chiusi in un campo di concentramento, eravamo 200-300 uomini, quando una notte i bombardieri americani colpirono la città. Usavano bombe ritardanti, che scoppiavano anche due giorni dopo. Al campo vennero due SS e chiesero al Lagerführer di dargli tre uomini. Scelse me, Antonio Sartori e Vittorio Caumo di Ronchi. Eravamo tre amici inseparabili. Ci mandarono a scavare una grande fossa attorno ad una bomba per permettere poi agli artificieri di disinnescarla. Le ore non passavano mai. Quando tornammo al campo per il pranzo dissi al Lagerführer, che mi voleva bene forse per via del mio cognome tedesco: “Laggiù non ci torno”. Al nostro posto mandò due marocchini e un italiano. Alle 15.30 si sentì una grande esplosione. Saltò in aria tutto: villa, tedeschi, italiani».
Nell'agosto 1944 altro trasferimento. «Ci portarono indietro verso Verdun. Io Antonio e Vittorio da tempo avevamo pianificato di scappare. Avevamo capito che ci avrebbero portato in Germania». Vissero nascosti nella boscaglia per più di 30 giorni nel bosco, mangiando quel che si trovava. Ovvero poco o nulla. Finché arrivarono nel paese di St. Mihiel dove alcune persone gli trovarono un nascondiglio in un cunicolo nascosto nel cimitero, dietro una lapide. «“Rimarrete nascosti qua fino a che non arriveranno gli americani”, ci dissero. “Vi porteremo da mangiare e da bere”. Un giorno arrivò il capo dei partigiani con tre mitra. Voleva che lo seguissimo in un’imboscata ai tedeschi. “Par noi la guerra es finì”, dissi spiaccicando qualche parola in francese. Non ce la perdonò».
Novembre 1944. «Arrivarono gli americani e i francesi vennero a prenderci per fare festa. Vedemmo arrivare per le strade del paese i carri armati americani, e ci diedero un pacchetto di sigarette e un chewing gum. La sera ci si trovava tutti dal capo-comune a fare festa. Durante uno di quei ritrovi arrivarono 10-12 partigiani con un camion, ci prelevarono e ci portarono in un penitenziario in città, a Verdun. ... Di domenica venivano, ci portavano legati in città e ci sputavano addosso. Prigionieri assieme a noi c’erano anche dei tedeschi. E le donne sospettate di aver collaborato con i tedeschi venivano violentate. Rimanemmo là dentro 20 giorni. Fino a che ci caricarono su un camion e ci portarono in campagna. C’era una “farma”, la chiamavano, una fattoria, recintata da mura. Ci ordinarono di metterci contro un muro, noi quattro e tre tedeschi. Capimmo che si stava mettendo molto male». Sorte volle che qualcuno avvisasse il comando americano. «Arrivarono appena in tempo, due camionette americane. Ci prelevarono e ci portarono con loro. Ci hanno dato qualche coperta, dei viveri».
Dicembre 1944. «Poi ci hanno portato a Compiègne dove ci trovavamo quando fu firmato il Trattato di pace e l’armistizio con la Francia. Era un campo di concentramento, eravamo in 15 mila. Noi italiani divisi dai tedeschi. Poi a Cherbourg e da lì mandarono i prigionieri in Inghilterra sulle navi; tra loro anche 250-300 italiani. Noi dovevamo partire con l’ultima nave; ma in Inghilterra erano saturi di prigionieri. Così ci fecero rimanere in Francia. Vi restammo per parecchio tempo».
Settembre 1945. «Una sera, all’improvviso, ci dissero: “Domani partite per l’Italia”. Ci portarono alla stazione di Le Mans e da lì partimmo alla volta di Novara dove arrivammo il 22 settembre 1945. Ci diedero la paga: 2.400 lire. Il giorno seguente, il 23 settembre, eravamo a casa».
Giovanni Pacher



Gruppo Alpini di Roncegno – Piazza Achille De Giovanni 1- 38050 – Roncegno Terme – (Tn) P.IVA/C.F.90012350220